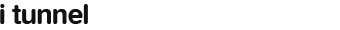In Italia sono 19, riempiono da mattino a sera i palinsesti settimanali delle tv e la rete che ne possiede di più è quella governata da Urbano Cairo, La7. Stiamo parlando dei talk show, il format di infotainment che padroneggia in Italia sin dalla sua prima comparsa nel 1995 grazie a Maurizio Costanzo. Anche se criticati, sconfessati e snobbati da molti, i talk show continuano a resistere (attualmente nessuno dei 19 rischia la chiusura), perché supportati dagli ascolti Auditel. Ma a che prezzo?
Anche quest’anno il Festival Internazionale del Giornalismo di Perugia (15-19 Aprile 2015) ha acceso i riflettori su questo modo di fare informazione in tv, coinvolgendo alcuni giornalisti del campo. Ad aprire il dibattito è Filippo Facci ("Libero"), che denuncia la costruzione eccessivamente artificiosa delle scalette dei talk. «Le scalette sono sempre eccessivamente costruite perché si precostituisce cosa una persona debba dire. Nello scegliere gli ospiti il conduttore sa già (o meglio presume) da che parte starà quel politico o opinionista. Poi ci sono persone che costruiscono un’intera sceneggiatura, come Santoro». Ma oltre alla competenza, uno dei principali ostacoli di chi mette in piedi questo tipo di format è il reperimento degli stessi ospiti della puntata. «Reperire gli ospiti oggi è difficilissimo per la numerosa offerta di talk e per l’appetibilità del personaggio che invito», dice Francesco Caldarola, autore di Ballarò. «Nel nostro programma abbiamo cercato di inserire interviste inedite a personaggi che non vanno spesso in tv (Prodi, Saviano, Bonino ecc), ma altri intervistati più competenti, ma meno noti, farebbero calare bruscamente la curva degli ascolti. È vero che Salvini va troppo in tv ma è un politico che indubbiamente alza lo share».
Ogni talk, poi, assume una sua identità in base al target di pubblico a cui è rivolto. «Io e Del Debbio (Quinta Colonna) indubbiamente facciamo due tipi di giornalismo diverso», afferma Corrado Formigli, conduttore di Piazza Pulita. Ma anche quando noi abbiamo raccontato l’assedio di Sirte (Libia) da parte dell’Isis, con un reportage esclusivo, lui ci ha battuti parlando di campi Rom, non nominando mai la parola Libia. Lo rispetto, ma facciamo due programmi diversi».
Il dubbio che sorge, quindi, è: perché alimentare sempre gli scontri politici interni e non affrontare situazioni geo-politiche di estrema importanza per l’Italia? Perché si preferisce al vero lavoro giornalistico, la baruffa tra politici? Continua Formigli: «Quest’anno rispetto all’anno scorso ho perso mezzo punto perché abbiamo aperto le finestre del nostro programma agli esteri, raccontando la situazione in Libia con reportage sul campo. Però il mio mestiere è quello di condurre un talk show, fatto di parola (talk) ma anche di intrattenimento (show). Raccontare gli esteri è difficile, perché richiede filmati potenti, che catturino l’attenzione dello spettatore di prima serata, che è facilmente soggetto a cambiare canale. Noi la mattina ci alziamo e ci rendiamo conto di essere giornalisti, ma dall’altra parte dobbiamo essere attenti anche al mercato. Se io non faccio ascolti per 3-4 settimane di seguito, mi chiudono il programma. E non vado a casa solo io ma anche 70-80 famiglie che lavorano dietro al programma. La mia è una rete commerciale che si finanzia con la pubblicità, altra cosa è il servizio pubblico. Lì vorremmo dei programmi fuori dalla logica degli ascolti».
Controbatte Facci dicendo che «la regola degli ascolti non può essere l’unica. Seguendo questa logica non si ha il coraggio di parlare dei temi di cui il giornalismo deve occuparsi. Perché in questi ultimi giorni nessun talk show ha approfondito il genocidio degli armeni? A me pare che ci sia un pubblico che si sta abituando all’intrattenimento». Sempre sul tema ascolti chiosa Marianna Aprile (Libero): «Nei talk show le nozze si fanno sempre in due. Gli autori e i conduttori possono sforzarsi di inserire novità o invitare nuovi ospiti, ma dall’altra parte deve esserci un pubblico che dice sì a questi cambiamenti. Perché se Formigli porta il reportage di Kobane in prima serata, ma poi non ha un riscontro di ascolti, questo non va. In generale il pubblico è pigro ad usufruire di informazioni e questo è un po’ colpa nostra».
L’imbarbarimento dei talk è anche responsabilità dei giornali che il più delle volte amplificano questi episodi. «Appena c’è una rissa in un talk show - dice il giornalista di La7 - i quotidiani online e non solo ne parlano subito in homepage. Quando invece mandiamo in onda inchieste interessanti nessuno le riprende. E poi dobbiamo sentirci criticare dagli stessi giornali il nostro modo di fare tv. Qui c’è ipocrisia».
Mentre la spada di Damocle dell’Auditel pende quotidianamente su conduttori e autori c’è chi si chiede se questo sistema, nel mondo del web 2.0, non sia troppo riduttivo (come già denunciato nel libro-inchiesta di R. Gisotti “La Favola dell’Auditel”). «Oggi c’è da valutare un numero maggiore di pubblici», dice Formigli. «Anche chi non ha il meter (lo strumento di rilevazione Auditel ndr) può guardare le puntate di Piazza Pulita in streaming, il giorno seguente su YouTube, o commentarle su Twitter. Dobbiamo conteggiare pure loro. Se conducessi un programma che non si basa sugli ascolti inserirei più esteri. Il mio grande sogno della vita sarebbe condurre un programma fatto solo da esteri». Alla proposta si unisce anche Caldarola di Ballarò: «Se non ci fossero gli ascolti sarebbe interessante affrontare l’ipotesi di uscita della Grecia dall’euro. Servirebbe a chiarire molte cose».